|
L’adolescenza, più delle altre fasi del ciclo di vita, è stata definita un periodo di transizione, caratterizzato da cambiamenti fisici, intellettivi, affettivi e sociali.
Rappresenta una fase critica e delicata per l’intera famiglia che ora, ancora più che nelle fasi precedenti, deve affrontare il delicato compito di integrare la legittima esigenza di indipendenza ed autonomia dei figli con la coesione degli affetti e con la negoziazione di nuove regole di rapporto [Camaioni, Di Blasio]. L’attenzione al ciclo di vita della famiglia si concretizza nel considerare l’adolescenza sia come un’impresa evolutiva congiunta di genitori e figli [Scabini, 1995] sia un periodo della vita caratterizzato dalla trasformazione dei legami precedenti. L'adolescenza di un figlio rappresenta un evento "critico" per tutto il sistema famigliare che è chiamato a confrontarsi con la necessità di realizzare un percorso che richiede anche ai genitori di riconsiderare la loro stessa adolescenza, di gestirne gli aspetti irrisolti e di riuscire a conciliare contenimento e flessibilità nell'aggiustamento delle distanze e nella ridefinizione dei confini e dei ruoli generazionali. Due sono i processi importanti in questa fase che si intrecciano tra loro: l’individuazione, propria dell’adolescente, che si esprime nella tendenza ad autonomizzarsi dai legami familiari e la differenziazione, propria dell’organizzazione familiare, dalla quale dipende il maggiore o minore grado di flessibilità nel consentire l’indipendenza dei suoi membri. L’adolescente che inizia a prendere le distanze dalle figure genitoriali avvia un processo di identificazione forte che lo porta a rinnegare in parte le identificazioni precedenti, sostanzialmente di tipo genitoriale, per cercare altrove figure identificatorie; queste lo aiuteranno a costruirsi un’identità propria, anche a partire dall’eredità genitoriale, ma ricomposta sulla base delle esperienze significative vissute autonomamente. Per avviare tale processo è necessario separarsi da chi fino ad oggi ha di fatto occupato la scena familiare. Ciò avviene attivando movimenti di allontanamento dai genitori, fisico e psichico, rinegoziando routine, regole ad abitudini consolidate nell’infanzia, modificando ruoli e mansioni più funzionali all’adolescente che sta cercando di transitare all’età adulta [Confalonieri, Gavazzi]. Quello compiuto dall’adolescente è allora un processo di “separazione psicologica” rispetto all’ambiente familiare e di ridefinizione della sua propria personalità [Tonolo, 1999]. Forte è quindi l’ambivalenza che caratterizza e direziona il legame fra genitori e figli: quello che si configura è un movimento di entrate ed uscite volontarie che l’adolescente compie per rispondere ai bisogni emancipativi ed evolutivi che avverte e contemporaneamente per garantirsi il rientro a casa e la sicurezza di essere ancora protetto. Garantire al figlio la possibilità di allontanarsi significa consentirgli di abbandonare una definizione di sé ancora infantile e costruirne una nuova a partire dalle esperienze che in autonomia sta compiendo, basate su desideri e bisogni, non più necessariamente congruenti con quelli dei genitori, da cui però si aspetta e chiede conferma e supporto. L’attaccamento ai genitori continua quindi a garantire la sicurezza, la “base sicura” nelle circostanze di vulnerabilità, paura e stress della vita quotidiana, soprattutto nelle nuove esperienze che l’adolescente si trova ad affrontare. Questo processo può portare a generare conflitti, normativi o valoriali, tra genitori e figli. Ma è solo attraverso il confronto, anche aspro e vivace, che si avviano quei processi di ristrutturazione dei rapporti familiari necessari per sostenere e promuovere la nuova fase del ciclo di vita familiare che comporterà la conquista dell’autonomia del figlio. Grazie ai conflitti e alla loro soluzione, l’adolescente apprende importanti abilità sociali e socio cognitive quali ascoltare, considerare le opinioni altrui, riflettere, unire punti di vista, venire a compromessi e negoziare. L’importanza del ruolo dei genitori, rispetto a quello svolto dai pari o da altre persone significative, viene ribadito anche nelle ricerche che hanno preso in esame alcune circostanze difficili o particolari nelle quali possono trovarsi i figli, ad esempio problemi psicologici, malattie fisiche, lutti. In questi casi è ancora più evidente che i genitori assumono un insostituibile ruolo protettivo, offrendo attenzione, affetto e incoraggiamento e riducendo l’effetto negativo di eventi di vita delicati o difficili e si configura come un fattore decisivo nello sviluppo della capacità dell’adolescente di far fronte ad eventi stressanti futuri [Hauser et al. 1985].
0 Comments
Leave a Reply. |
Emma Montorfano
Categorie
Tutti
Archivi
Febbraio 2023
|
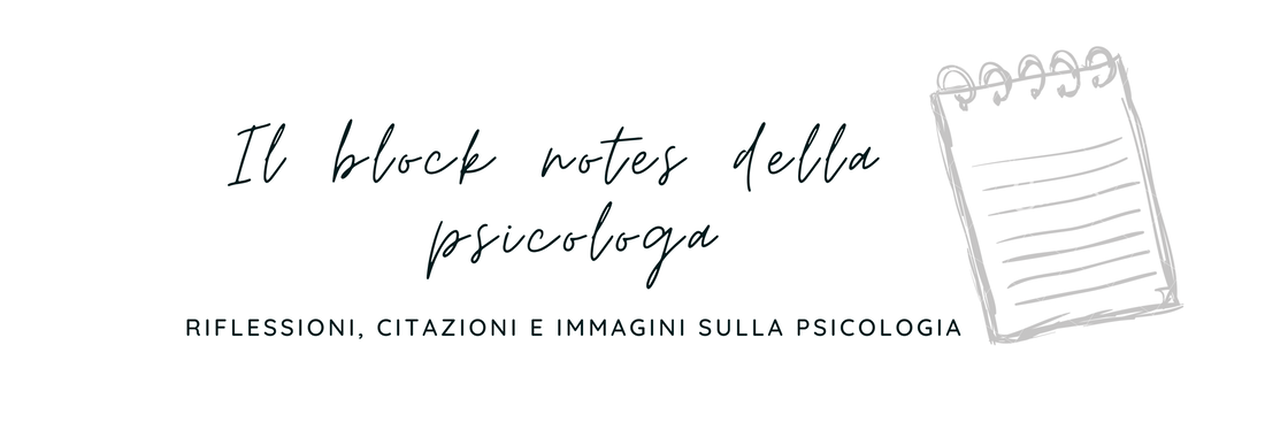

 Feed RSS
Feed RSS
