|
In un articolo del blog alleyoop.ilsole24ore.com l'insegnante Antonella Bonavoglia scrive a proposito dell'importanza del gioco simbolico: Lucia e Martina sembra che stiano litigando. “Facciamo finta che io sono la mamma e tu la figlia!” “No! Voglio essere io la mamma!” Il desiderio di intervenire in questo tipo di litigi, in classe, è forte. Potrei richiamare le bambine, calmando la loro rabbia e, magari riportandole al silenzio. Ma non lo faccio e vi spiego perché. Il giocare “a fare finta” è una modalità ludica importantissima, sempre meno utilizzata, purtroppo. Le due bambine non stanno semplicemente litigando; stanno misurandosi, si stanno confrontando, cercando di capire fino a che punto spingersi, fino a che punto insistere o meno, fino a che punto cedere. Si stanno conoscendo, stanno attuando strategie nuove di comunicazione e di socializzazione. Non solo. Stanno immaginando: di essere altrove, di essere altro. In quel momento stanno fantasticando di essere due donne adulte, stanno scegliendo il proprio ruolo e, anche se non è evidente, la loro personalità si espande, verso l’esterno, cercando di pensare a situazioni future o riproponendo scene già viste. Lo psicologo Jean Piaget, ha analizzato, nel corso della sua carriera, questa particolare modalità di gioco, denominata “gioco simbolico”. Si sviluppa a partire dai due anni di età e continua fino agli otto, circa. In questo periodo i bambini cominciano ad adoperare il pensiero simbolico in quanto acquisiscono la capacità rappresentativa, cioè sono in grado di rappresentarsi mentalmente cose, oggetti, situazioni, persone indipendentemente dalla loro presenza. I bambini sono in grado di compiere imitazioni differite, cioè di rappresentare azioni passate delle quali sono stati testimoni (come pettinare la bambola allo stesso modo della madre che pettina la sorellina). Frutto di tale fenomeno è il gioco “far finta di”, appunto il gioco simbolico, che presuppone un’imitazione differita (correre sopra un cavallo) e delle combinazioni mentali (usare il manico di scopa al posto del cavallo). Piaget (1962) ha posto in stretta relazione il gioco e lo sviluppo cognitivo dei bambini. Durante il secondo anno di vita le azioni di gioco diventano ancora più complesse coinvolgendo oggetti che a loro volta possono diventare altri oggetti, come un cubo che diventa una torre. Il gioco diventa così simbolico o di rappresentazione, perché costituisce un mezzo per mettere in atto delle scene simboliche. I bambini nativi digitali, hanno a disposizione una vasta gamma di giochi, adatti alla loro crescita e al potenziamento delle loro abilità cognitive. Pensiamo all’importanza della robotica e dell’informatica: attraverso l’interazione con dispositivi elettronici, è possibile sviluppare il problem solving, la capacità di ragionamento, di interpretazione della realtà. Eppure, sembra avere sempre meno spazio, il gioco libero. A volte viene visto, soprattutto in classe, una “perdita di tempo”. A scuola dell’infanzia, invece, ad esempio, è importantissimo lasciare dei momenti “vuoti” , in cui i bambini possano sentirsi liberi di muoversi e di inventare giochi, senza l’intervento dell’insegnante. E’, tra l’altro, un modo per osservare gli alunni, i loro comportamenti, le loro scelte, il loro modo di comunicare, la loro capacità di autonomia. E’ sorprendente ciò che i bambini riescono a fare solo con l’immaginazione e quanto si riesca a scoprire della loro personalità, semplicemente, osservandoli. Nel periodo estivo, quando le giornate dei piccoli non sono scandite da impegni scolastici, sportivi e ricreativi, sarebbe davvero opportuno ritrovare una sensazione fastidiosa e allo stesso tempo preziosa: la noia. E’ proprio nei momenti “vuoti” che si nasconde la scintilla della creatività, è proprio qui che si sviluppa il gioco simbolico. La fondamentale importanza dell’aspetto ludico nel favorire l’apprendimento deve essere sempre ricordata dagli educatori e dagli adulti, in generale. Troppo spesso si toglie tempo al gioco libero, privilegiando altre attività considerate più formative. Invece, attraverso il gioco, il bambino acquista autonomia, sviluppa la sua identità e arricchisce anche le sue competenze, che lo aiuteranno a trovare un posto nel mondo. Articolo di Antonella Bonavoglia Solitamente non è prevedibile con precisione l’imminente arrivo di un disastro naturale, poiché sono scarse le indicazioni che possono aiutare a stabilire se l’evento sta per accadere. In genere si verificano in uno spazio temporale breve, ma le conseguenze che portano con sé sono devastanti.
Innanzitutto comportano una grave minaccia alla vita, sia direttamente che indirettamente, poiché i sopravvissuti spesso sono testimoni della morte di altre persone. Inoltre lasciano poche o nessuna possibilità di controllo sulla situazione, alimentando un clima di caos e sensazione di impotenza. Caratteristica fondamentale è che ad essere colpita non è una singola persona ma l’intera comunità. Il coinvolgimento di molte persone simultaneamente crea una situazione che viene percepita come un disordine generalizzato, come la fine del mondo. L’evento stressante in sé è la principale fonte delle conseguenti reazioni delle vittime. Tuttavia la sofferenza, specialmente nel caso di calamità di massa, non è confinata all’evento. Il trauma non si esaurisce una volta che l’evento è passato, ma prosegue, seguito da un secondo disastro, ovvero dagli effetti della reazione al disastro (Kapor Stanulovic, 2005). La distruzione causata da eventi climatici e disastri geologici è purtroppo conosciuta in tutto il mondo. Generalmente gli effetti fisici di un disastro sono evidenti. Decine, centinaia, migliaia di persone perdono la vita; molti superstiti sono feriti o invalidi; case, luoghi di lavoro, beni personali e attrezzature risultano distrutti o danneggiati. La ricerca di Bland e colleghi (1996) sulle vittime del terremoto ha rilevato che i problemi di salute mentale sono peggiori fra le persone con maggiori perdite materiali Anche se, in generale, sono gli effetti emotivi di un disastro che causano più sofferenza. Nei giorni e nelle settimane che seguono il disastro può emergere un ampio ventaglio di disturbi emotivi. Nella maggior parte dei casi i sintomi recedono gradualmente ma, nelle dodici settimane successive, dal 20% al 50% delle vittime possono mostrare ancora evidenti sintomi. La maggior parte delle vittime non mostra più sintomi nel giro di un anno o due, anche se almeno un quarto di esse può ancora presentare disturbi significativi. Può accadere inoltre che alcune vittime che in precedenza apparivano esenti da sintomi comincino a mostrarne a un anno o due dal disastro (Kapor Stanulovic, 2005). Accade, infatti, che il sollievo iniziale, dovuto al fatto di essere stati salvati, e l’iniziale ottimismo per una rapida ripresa possono indurre uno stato d’animo euforico. Tuttavia, successivamente, può affiorare la consapevolezza che le perdite personali e materiali sono irreversibili, che le persone decedute non ritorneranno, che i vuoti creatisi in famiglia sono permanenti, che il posto di lavoro è definitivamente perduto. Dopo un certo lasso di tempo, a volte considerevole, gli stimoli associati al disastro fanno riaffiorare ricordi precedentemente rimossi e come risultato fanno scattare reazioni psichiche. Gli anniversari, per esempio, possono essere momenti particolarmente difficili, in cui ricompaiono, temporaneamente e senza preavviso, i sintomi che ormai si credevano superati. Si hanno notizie di vittime internate nei campi di concentramento nazisti che iniziarono a manifestare i sintomi post traumatici a distanza di anni dopo la liberazione (Pietrantoni, Prati, 2009). Oltre a ripercuotersi direttamente sulle singole vittime, i disastri provocano lacerazioni nel tessuto sociale. Possono recidere i legami che uniscono le persone all’interno di famiglie, gruppi di lavoro, intere comunità e società. I disastri possono materialmente distruggere istituzioni simboliche della comunità, come scuole e chiese, oppure interromperne l’attività. Ne deriva un profondo senso di vuoto legato all’appartenenza ad un gruppo che purtroppo si è sfaldato o che può non ritornare più come in precedenza. Si possono perdere familiari, amici e vicini di casa, ci si addolora per la loro scomparsa e ci si meraviglia della propria sopravvivenza. A volte si è costretti a ricreare una comunità dal nulla e vivere a contatto con persone magari sconosciute o culturalmente lontane. Tutto ciò procura effetti negativi sull’identità, poiché viene minato il senso di appartenenza che nasce dal vivere all’interno di una comunità. Il sentirsi parte di un gruppo suscita sentimenti positivi per l’autostima e porta alla condivisione di valori, credenze e norme comportamentali (Smith, Mackie, 2000). Una catastrofe può stravolgere la consapevolezza di appartenere ad un gruppo ripercuotendosi in modo negativo sulla costruzione dell’identità. A volte lo strappo dalla propria terra è radicale. Nel 2006, con la direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri, si è avuto in Italia l’ingresso ufficiale dell’intervento di tipo psicosociale nell’ambito delle operazioni di supporto a seguito di un disastro, grazie alla quale sono stati adottati gli indirizzi operativi relativi ai cosiddetti “Criteri di massima sugli interventi psicosociali da adottare nelle catastrofi” << Gazzetta Ufficiale>> n. 200 del 29 agosto 2006 Un intervento a carattere psicosociale si basa su due componenti fondamentali. La prima componente rimanda all’aspetto psicologico, che si focalizza su sentimenti, pensieri, credenze, attitudini e valori, ovvero sulle componenti interiori dell’individuo. Queste caratteristiche sono da considerare come risorse interne fondamentali. La persona infatti conferisce valore e significato al mondo esterno e così facendo riesce ad adattarsi ad esso. Dall’altro lato però, grazie alle proprie risorse, è in grado di agire su di esso e di modificarlo secondo le proprie esigenze. In questa ottica lo sviluppo psicologico dell’individuo non è da intendersi come una semplice acquisizione o trasformazione di abilità e capacità, ma come l’insieme di processi entro cui la persona e l’ambiente interagiscono. Risulta il frutto di un processo che coinvolge congiuntamente le caratteristiche della persona e il suo ambiente ecologico (Bronfenbrenner, 1986). La seconda componente è di tipo sociale e fa riferimento ai contesti e alla rete di relazioni in cui l’individuo è inserito. L’attenzione qui verte sulle interazioni, sui comportamenti, sui valori culturali e sullo spazio di vita, come definito da Lewin (Smith, Mackie, 2000). Negli ultimi anni, con lo sviluppo di ricerche in ambito preventivo su soggetti a rischio e traumatizzati, gli apporti della psicologia clinica e della psicologia dell’emergenza concordano nel riconoscere la possibilità di superamento di eventi traumatici nella interconnessione tra le risorse psicologiche interne, presenti nell’individuo al momento del trauma, e le risorse esterne, messe a disposizione dell’ambiente circostante. Di conseguenza, condurre un intervento psicosociale significa prestare attenzione contemporaneamente alla persona e all’ambiente in cui questa è inserita, osservando le possibili connessioni e implicazioni che possono presentarsi. È indispensabile prendere in considerazione le specificità del contesto, del gruppo in cui l’individuo è inserito e del soggetto stesso, in modo da rendere l’intervento il più funzionale possibile per quel destinatario specifico in quella particolare situazione. Ogni qual volta si decide si progettare un intervento è importante includere attività ed interventi che possano dunque proporre situazioni concrete in cui siano presenti: la garanzia dei bisogni primari di accudimento e di relazione; l’accettazione profonda della persona, che permetta l’accoglimento, la condivisione e la comprensione empatica; il riconoscimento delle risorse, poiché queste possono essere utilizzate solo se diventano visibili; ed infine la pluralità di proposte operative, per potenziare la creatività ed aprire orizzonti nuovi verso il futuro (Cecchetto, 2008). |
Emma Montorfano
Categorie
Tutti
Archivi
Febbraio 2023
|



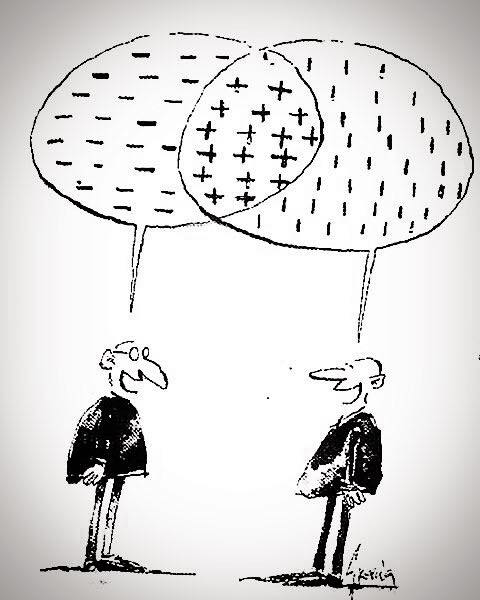

 Feed RSS
Feed RSS
