|
Viviamo in una cultura in cui il linguaggio verbale è il canale principale con il quale interagiamo. È interessante notare come il linguaggio del corpo sia definito "non verbale", come una negazione di qualcosa piuttosto che come la presenza di altro.
Ma sperimentiamo quotidianamente quanto anche il corpo sia comunicativo. Si attiva, si arrabbia, si agita, salta, respinge, si avvicina... risponde agli stimoli esterni in connessione con il cervello. A livello fisiologico questa connessione è molto vivida. Ci sono episodi infatti in cui il sistema di allarme del cervello, di fronte ad una minaccia alla nostra "sopravvivenza"( pensiamo ad una aggressione ad esempio), fa innescare automaticamente una risposta programmata del corpo: la nostra mente cosciente si spegne parzialmente e il corpo si prepara a correre, a nascondersi, a combattere, a congelarsi. Prima di essere pienamente consapevoli della situazione, il nostro corpo può già essere in movimento. Se queste risposte hanno successo e riusciamo a sfuggire al pericolo, recuperiamo il nostro equilibrio interno e gradualmente riconquistiamo i nostri sensi. Ma non sempre, per fortuna, viviamo questo tipo di esperienze. A volte però sono eventi della vita molto dolorosi, molto stressanti, estremamente faticosi, che portano con sé un carico emotivo complesso, manifestato nel corpo. Per riuscire ad andare avanti, può capitare di silenziare la parte emotiva, di non volerla o poterla guardare (occhio non vede, cuore non duole), di non sapere come gestirla, o cosa farsene. Si passa oltre. Ma è come se il corpo sapesse che non si può stare meglio fintanto che non ci si confronta con le sensazioni corporee, le emozioni e i significati che queste assumono per la persona. Così "fa ancora più chiasso", come un bambino che vuole essere ascoltato e guardato dal proprio genitore. Può attivarsi di più (ansia, rabbia, paura e si sente la perdita di controllo), si può spegnere in modo drastico (apatia, ritiro), può attirare l'attenzione producendo nuovi sintomi (mal di testa, insonnia, problemi intestinali, vomito, dermatiti etc), può agire anche attraverso la violenza, verso sé e verso gli altri. Può essere difficile mettere in parole queste sensazioni. Il linguaggio verbale infatti si è evoluto principalmente per condividere le "cose là fuori" non per comunicare la nostra interiorità. Il centro del linguaggio, nel cervello, si trova nell'area più lontana possibile dal centro di percezione del proprio sé, di chi si è. Insomma, si fatica non poco a dare forma e complessità (chi è in terapia lo sa bene). La percezione delle sensazioni corporee, l'osservazione del modo in cui il corpo interagisce con il mondo, sono fondamentali per la consapevolezza emotiva. Da qui si può ripartire per recuperare le parole, per narrarsi e trovare così un senso a quanto vissuto, collocandolo nella propria storia.
0 Comments
Spesso sentiamo di avere il controllo della situazione quando sappiamo cosa e come fare, quando abbiamo ben chiari cause ed effetti, quando conosciamo i passi da compiere con precisione.
A volte però non è così. E possiamo sentire di avere il controllo della situazione quando NON facciamo, quando scegliamo di fermarci, quando mettiamo in standby un futuro che ci spaventa. Anche queste azioni possono farci sentire di avere tutto sotto controllo, darci un senso di protezione. Nonostante non sia magari ciò che fa stare meglio. Se siete interessati a conoscere più in dettaglio l'arte del Kintsugi, potete leggere l'articolo "Le cicatrici d'oro" Vi propongo tre spunti di riflessione sulla tematica: una immagine, un testo e un aforisma. Quanto è importante, dopo una ferita, andare avanti e non fermarsi? Quanto ci costa fermarci? E quanto è difficile ripartire? Cosa vediamo dietro di noi e cosa ci aspetta davanti? Una cicatrice sulla pelle è qualcosa che a volte vorremmo nascondere e i motivi possono essere tanti. E così può succedere anche per le "cicatrici" che ci hanno lasciato tutte quelle esperienze che ci hanno ferito e fatto soffrire. Le nascondiamo per vergogna, per non provare più dolore, perchè ci sentiamo in colpa, perché ci fanno rabbia, per non essere nuovamente feriti o per paura di non essere accettati. Alcune esperienze ci lasciano profonde ferite. Ma il processo di cicatrizzazione, seppur doloroso e faticoso, può insegnarci molto, soprattutto su noi stessi.
Il Kintsugi (letteralmente “riparare con l’oro”), è una tecnica giapponese che consiste nel ricostruire oggetti rotti o fratturati con un materiale prezioso, l’oro, di solito, unito a un collante naturale (farina e acqua). Nel Kintsugi, “il gesto riparativo, l’arte dell’attesa, della precisione e della pazienza” dona ancora più valore al manufatto, che da oggetto di uso comune diventa un oggetto “artistico”. In altre parole, l’oggetto non viene gettato via – come spesso accade quando rompiamo qualche cosa – ma acquista una nuova qualità, che lo arricchisce e ne accresce il valore estetico. Video su "Internazionale" : la storia e il vero significato del kintsugi, l'arte delle preziosi cicatrici l Kintsugi ha potente valore simbolico: sottolinea come la cura delle ferite possa non solo permetterci di guarire, ma renderci in qualche modo più “preziosi".
L'importanza di mettere insieme i propri cocci e continuare a vivere è una metafora della vita, semplice e tutt’altro che banale. Una persona che attraversa un momento doloroso e drammatico deve non solo rimettere insieme i pezzi e a valorizzare le proprie e cicatrici, ma anche andare oltre. Che cosa insegna quest’arte giapponese? Spesso tendiamo ad attribuire alla crisi e al senso di vuoto, di dolore e di sofferenza che ne consegue un valore solo negativo: il percorso terapeutico permette di affrontare l’esperienza dolorosa come un momento di crescita che, “riparando la frattura con l’oro”, tiene di nuovo insieme i pezzi e dona una nuova forma, più ricca della precedente. Inoltre aiuta a comprendere che per cambiare può essere necessario passare attraverso un disagio, una “rottura”. La bellezza prende forma proprio dalle imperfezioni e dalle fragilità. Solitamente non è prevedibile con precisione l’imminente arrivo di un disastro naturale, poiché sono scarse le indicazioni che possono aiutare a stabilire se l’evento sta per accadere. In genere si verificano in uno spazio temporale breve, ma le conseguenze che portano con sé sono devastanti.
Innanzitutto comportano una grave minaccia alla vita, sia direttamente che indirettamente, poiché i sopravvissuti spesso sono testimoni della morte di altre persone. Inoltre lasciano poche o nessuna possibilità di controllo sulla situazione, alimentando un clima di caos e sensazione di impotenza. Caratteristica fondamentale è che ad essere colpita non è una singola persona ma l’intera comunità. Il coinvolgimento di molte persone simultaneamente crea una situazione che viene percepita come un disordine generalizzato, come la fine del mondo. L’evento stressante in sé è la principale fonte delle conseguenti reazioni delle vittime. Tuttavia la sofferenza, specialmente nel caso di calamità di massa, non è confinata all’evento. Il trauma non si esaurisce una volta che l’evento è passato, ma prosegue, seguito da un secondo disastro, ovvero dagli effetti della reazione al disastro (Kapor Stanulovic, 2005). La distruzione causata da eventi climatici e disastri geologici è purtroppo conosciuta in tutto il mondo. Generalmente gli effetti fisici di un disastro sono evidenti. Decine, centinaia, migliaia di persone perdono la vita; molti superstiti sono feriti o invalidi; case, luoghi di lavoro, beni personali e attrezzature risultano distrutti o danneggiati. La ricerca di Bland e colleghi (1996) sulle vittime del terremoto ha rilevato che i problemi di salute mentale sono peggiori fra le persone con maggiori perdite materiali Anche se, in generale, sono gli effetti emotivi di un disastro che causano più sofferenza. Nei giorni e nelle settimane che seguono il disastro può emergere un ampio ventaglio di disturbi emotivi. Nella maggior parte dei casi i sintomi recedono gradualmente ma, nelle dodici settimane successive, dal 20% al 50% delle vittime possono mostrare ancora evidenti sintomi. La maggior parte delle vittime non mostra più sintomi nel giro di un anno o due, anche se almeno un quarto di esse può ancora presentare disturbi significativi. Può accadere inoltre che alcune vittime che in precedenza apparivano esenti da sintomi comincino a mostrarne a un anno o due dal disastro (Kapor Stanulovic, 2005). Accade, infatti, che il sollievo iniziale, dovuto al fatto di essere stati salvati, e l’iniziale ottimismo per una rapida ripresa possono indurre uno stato d’animo euforico. Tuttavia, successivamente, può affiorare la consapevolezza che le perdite personali e materiali sono irreversibili, che le persone decedute non ritorneranno, che i vuoti creatisi in famiglia sono permanenti, che il posto di lavoro è definitivamente perduto. Dopo un certo lasso di tempo, a volte considerevole, gli stimoli associati al disastro fanno riaffiorare ricordi precedentemente rimossi e come risultato fanno scattare reazioni psichiche. Gli anniversari, per esempio, possono essere momenti particolarmente difficili, in cui ricompaiono, temporaneamente e senza preavviso, i sintomi che ormai si credevano superati. Si hanno notizie di vittime internate nei campi di concentramento nazisti che iniziarono a manifestare i sintomi post traumatici a distanza di anni dopo la liberazione (Pietrantoni, Prati, 2009). Oltre a ripercuotersi direttamente sulle singole vittime, i disastri provocano lacerazioni nel tessuto sociale. Possono recidere i legami che uniscono le persone all’interno di famiglie, gruppi di lavoro, intere comunità e società. I disastri possono materialmente distruggere istituzioni simboliche della comunità, come scuole e chiese, oppure interromperne l’attività. Ne deriva un profondo senso di vuoto legato all’appartenenza ad un gruppo che purtroppo si è sfaldato o che può non ritornare più come in precedenza. Si possono perdere familiari, amici e vicini di casa, ci si addolora per la loro scomparsa e ci si meraviglia della propria sopravvivenza. A volte si è costretti a ricreare una comunità dal nulla e vivere a contatto con persone magari sconosciute o culturalmente lontane. Tutto ciò procura effetti negativi sull’identità, poiché viene minato il senso di appartenenza che nasce dal vivere all’interno di una comunità. Il sentirsi parte di un gruppo suscita sentimenti positivi per l’autostima e porta alla condivisione di valori, credenze e norme comportamentali (Smith, Mackie, 2000). Una catastrofe può stravolgere la consapevolezza di appartenere ad un gruppo ripercuotendosi in modo negativo sulla costruzione dell’identità. A volte lo strappo dalla propria terra è radicale. Nel 2006, con la direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri, si è avuto in Italia l’ingresso ufficiale dell’intervento di tipo psicosociale nell’ambito delle operazioni di supporto a seguito di un disastro, grazie alla quale sono stati adottati gli indirizzi operativi relativi ai cosiddetti “Criteri di massima sugli interventi psicosociali da adottare nelle catastrofi” << Gazzetta Ufficiale>> n. 200 del 29 agosto 2006 Un intervento a carattere psicosociale si basa su due componenti fondamentali. La prima componente rimanda all’aspetto psicologico, che si focalizza su sentimenti, pensieri, credenze, attitudini e valori, ovvero sulle componenti interiori dell’individuo. Queste caratteristiche sono da considerare come risorse interne fondamentali. La persona infatti conferisce valore e significato al mondo esterno e così facendo riesce ad adattarsi ad esso. Dall’altro lato però, grazie alle proprie risorse, è in grado di agire su di esso e di modificarlo secondo le proprie esigenze. In questa ottica lo sviluppo psicologico dell’individuo non è da intendersi come una semplice acquisizione o trasformazione di abilità e capacità, ma come l’insieme di processi entro cui la persona e l’ambiente interagiscono. Risulta il frutto di un processo che coinvolge congiuntamente le caratteristiche della persona e il suo ambiente ecologico (Bronfenbrenner, 1986). La seconda componente è di tipo sociale e fa riferimento ai contesti e alla rete di relazioni in cui l’individuo è inserito. L’attenzione qui verte sulle interazioni, sui comportamenti, sui valori culturali e sullo spazio di vita, come definito da Lewin (Smith, Mackie, 2000). Negli ultimi anni, con lo sviluppo di ricerche in ambito preventivo su soggetti a rischio e traumatizzati, gli apporti della psicologia clinica e della psicologia dell’emergenza concordano nel riconoscere la possibilità di superamento di eventi traumatici nella interconnessione tra le risorse psicologiche interne, presenti nell’individuo al momento del trauma, e le risorse esterne, messe a disposizione dell’ambiente circostante. Di conseguenza, condurre un intervento psicosociale significa prestare attenzione contemporaneamente alla persona e all’ambiente in cui questa è inserita, osservando le possibili connessioni e implicazioni che possono presentarsi. È indispensabile prendere in considerazione le specificità del contesto, del gruppo in cui l’individuo è inserito e del soggetto stesso, in modo da rendere l’intervento il più funzionale possibile per quel destinatario specifico in quella particolare situazione. Ogni qual volta si decide si progettare un intervento è importante includere attività ed interventi che possano dunque proporre situazioni concrete in cui siano presenti: la garanzia dei bisogni primari di accudimento e di relazione; l’accettazione profonda della persona, che permetta l’accoglimento, la condivisione e la comprensione empatica; il riconoscimento delle risorse, poiché queste possono essere utilizzate solo se diventano visibili; ed infine la pluralità di proposte operative, per potenziare la creatività ed aprire orizzonti nuovi verso il futuro (Cecchetto, 2008). Articolo dell'Espresso del 15 giugno 2017 Da un estratto di questo interessante articolo, si legge che: “Il vero problema che dobbiamo affrontare oggi riguardo alla salute di chi sbarca sulle nostre coste non è rappresentato dalle gravi malattie infettive e diffusive, la cui incidenza è assai contenuta per il fenomeno del “migrante sano” ormai ampiamente dimostrato dai dati, ma dal disagio psicologico di queste persone” “Dal punto di vista della salute mentale, l’effetto migrante sano tende a esaurirsi rapidamente, già prima dell’arrivo, a seguito delle condizioni spesso estreme in cui il percorso migratorio si compie: coloro che arrivano, donne, uomini e bambini, sono estremamente vulnerabili e manifestano forme reattive quali depressione, disturbi di adattamento, disordini post-traumatici da stress, stati d’ansia” spiega Giovanni Baglio, epidemiologo della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), che continua nell'articolo la sua riflessione. Io aggiungo che negli ultimi trenta anni sono state numerose le crisi umanitarie, conseguenza diretta di guerre e genocidi, che si sono succedute nel tempo e che hanno causato milioni di sfollati e rifugiati in tutto il mondo. Le persone che sono costrette ad abbandonare i loro paesi sono sempre più spesso portatori di sofferenza psicologica. La migrazione, infatti, al di là delle molteplici spinte che stanno alla base di essa e del significato che assumono, rappresenta soprattutto un processo di ridefinizione identitaria che coinvolge le dimensioni più intime della persona: le convinzioni, i valori, il carattere, gli affetti, la capacità di fare progetti per il futuro. Lasciare il proprio paese e andare verso la salvezza significa continuare a pagare un prezzo molto alto: la rottura dei legami familiari, i sensi di colpa o la perdita del ruolo sociale. A questo si aggiungono tutte quelle situazioni stressanti che vengono vissute durante il percorso della migrazione e che possono diventare eventi potenzialmente traumatici, causa di malessere psicologico profondo: si cita ad esempio il subire violenze o torture, vivere in condizioni difficili e provvisorie, la violazione di diritti umani, la mancata integrazione. Nel vissuto della migrazione si vive una serie di fasi: il periodo della solitudine, momento che va dal distacco dal proprio paese alla consapevolezza sulla necessità di modificare la propria visione del mondo; e il periodo della rielaborazione personale nel quale il possesso di strumenti culturali adeguati aiuta a razionalizzare e a orientare proficuamente l'esperienza [C. Mariti, 2003]. E' un processo complesso e delicato, che può non trovare un esito positivo se non si offre un sostegno adeguato, quando il benessere psicologico diventa precario. Tra le capacità personali, la resilienza si configura come un processo che permette di far fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a riorganizzare positivamente la propria vita, nonostante le situazioni difficili vissute e il probabile esito negativo. Se adeguatamente supportati e alimentati, i processi resilienti, personali e sociali, possono essere alla base della ripresa di fronte alla catastrofe. (Cyrulnik, 2008). La persona logorata e ferita, dal punto di vista psicologico, ricostruisce il suo benessere entrando in relazione con altre persone e sperimentando la sensazione di fiducia, il senso di identità e di competenza. L'essere parte di un gruppo dove possono essere condivise esperienze ed emozioni è spesso una prima tappa per uscire dall'emarginazione e creare legami. I migranti sono soggetti attivi che mettono in campo capacità relazionali, competenze lavorative e professionali, conoscenze culturali, attuando di volta in volta strategie di adattamento alle diverse situazioni che si trovano ad affrontare. È nella narrazione di storie di vita individuali e collettive che la progettualità futura può affiorare. Sono storie di vita che mostrano che il cambiamento è possibile. Storie che devono essere ascoltate. |
Emma Montorfano
Categorie
Tutti
Archivi
Febbraio 2023
|




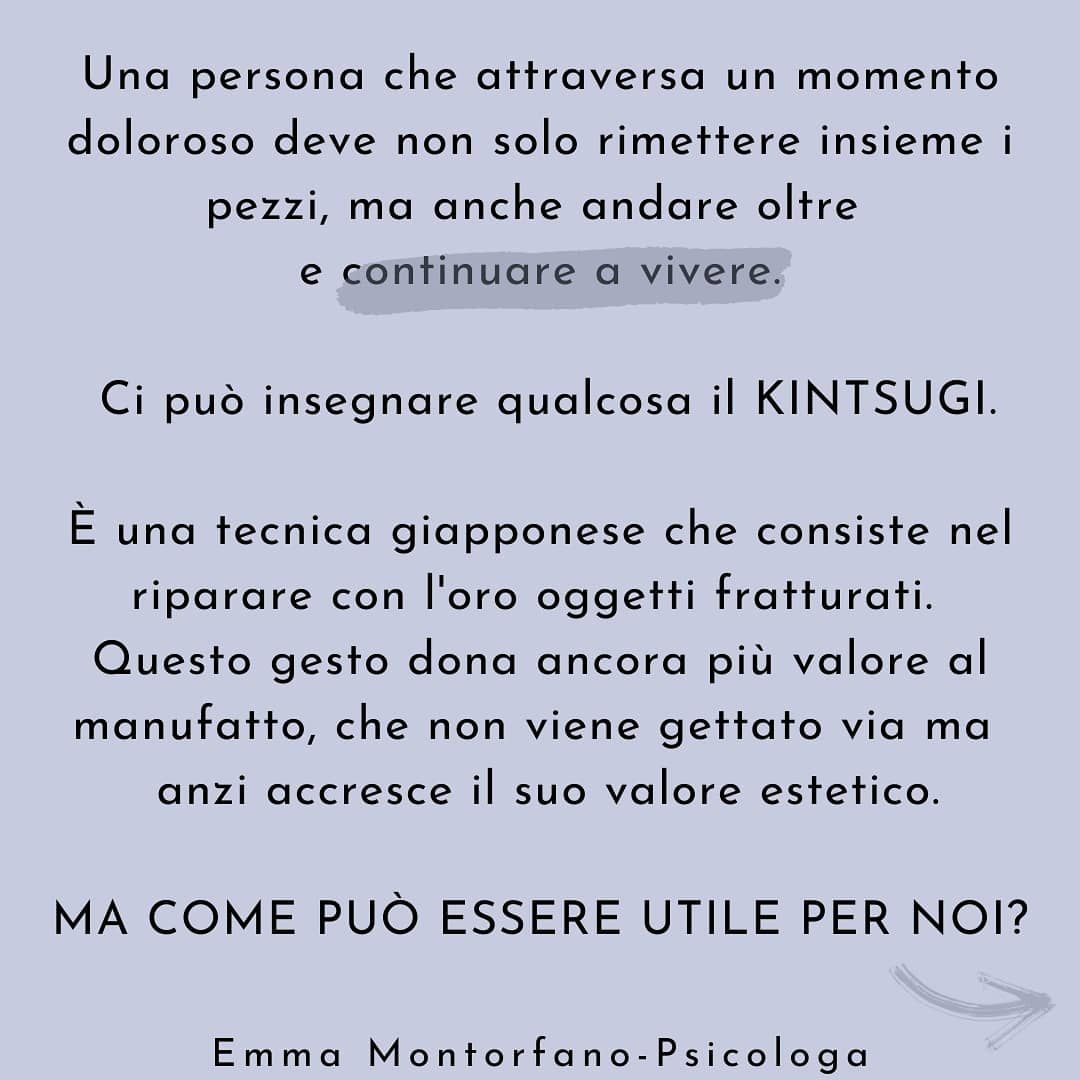
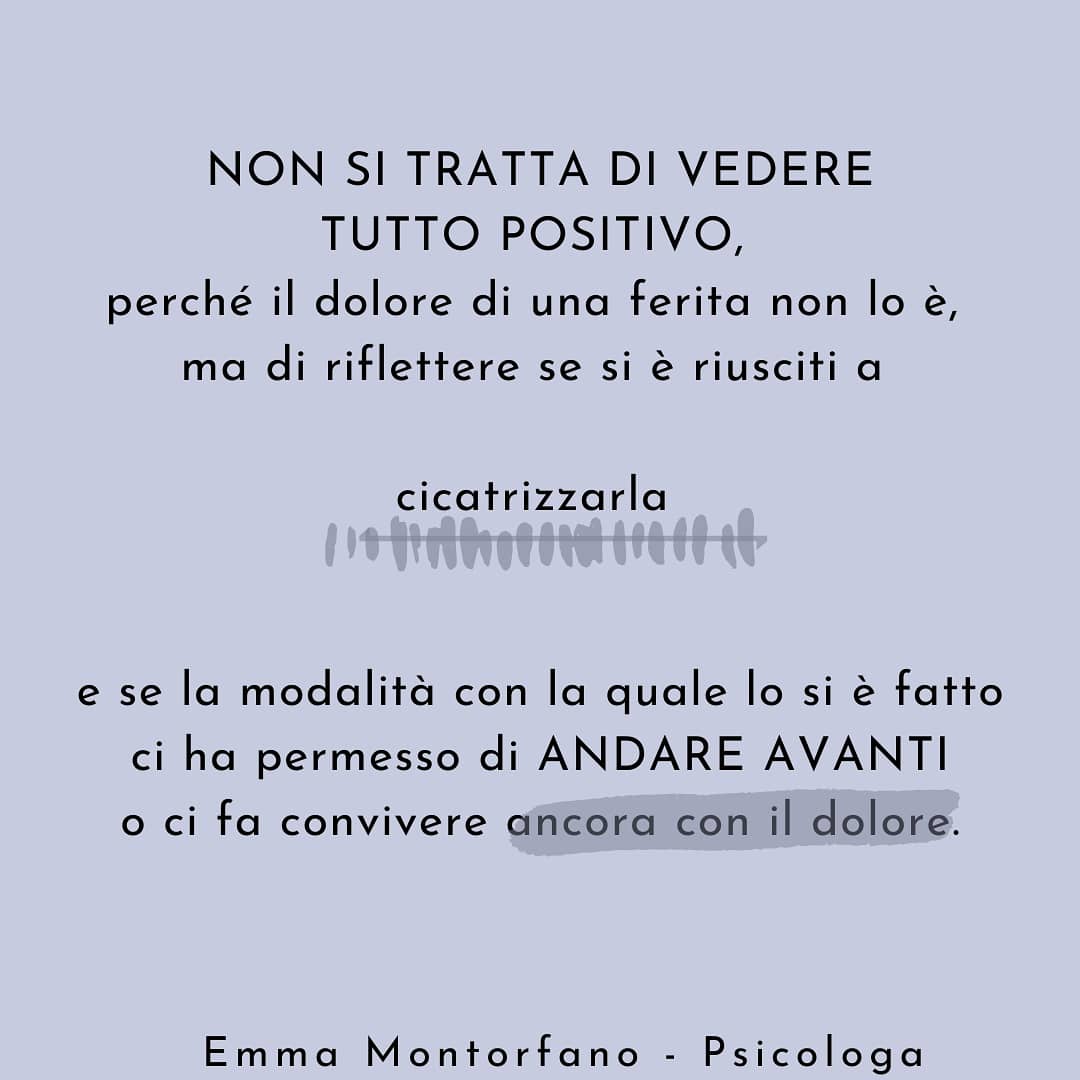
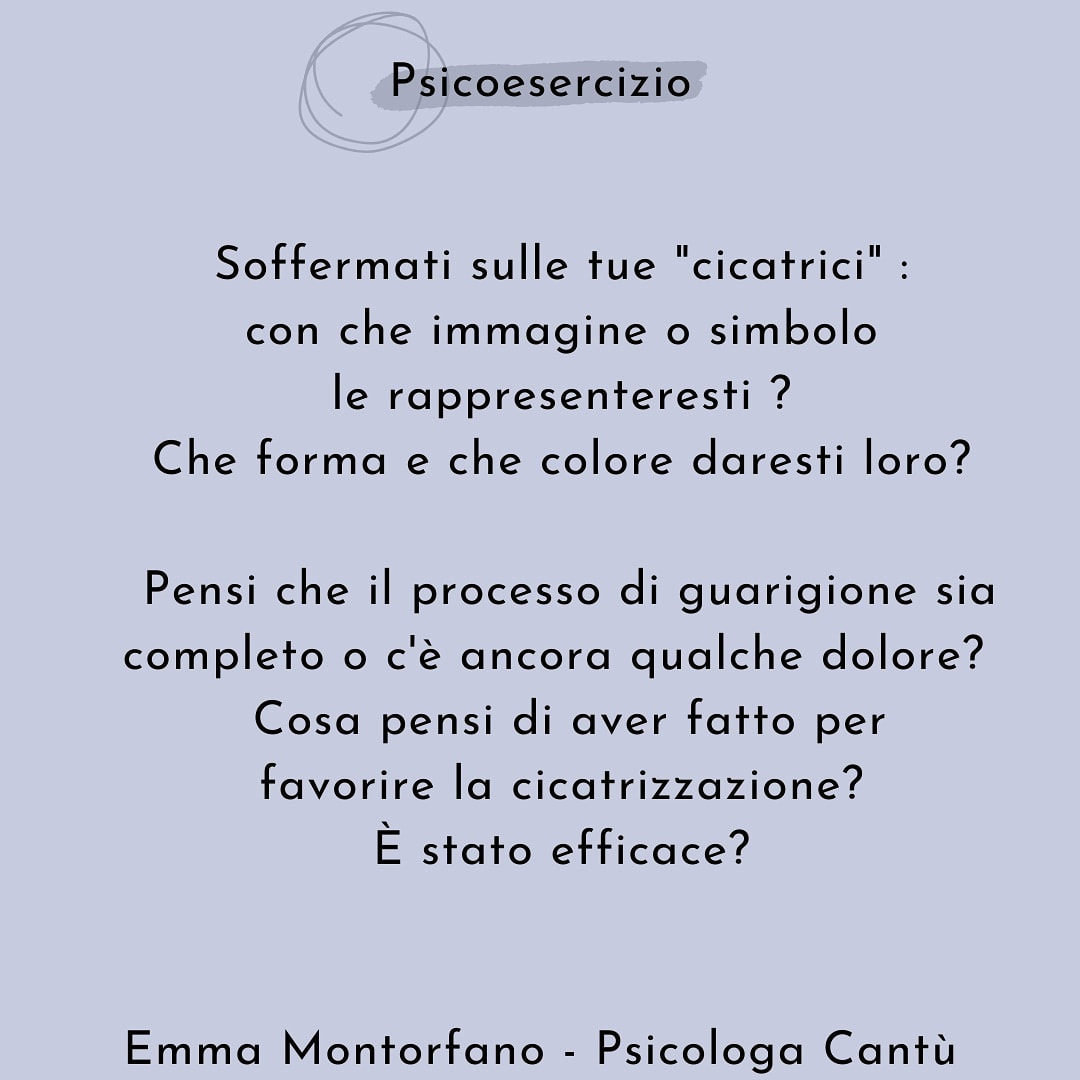

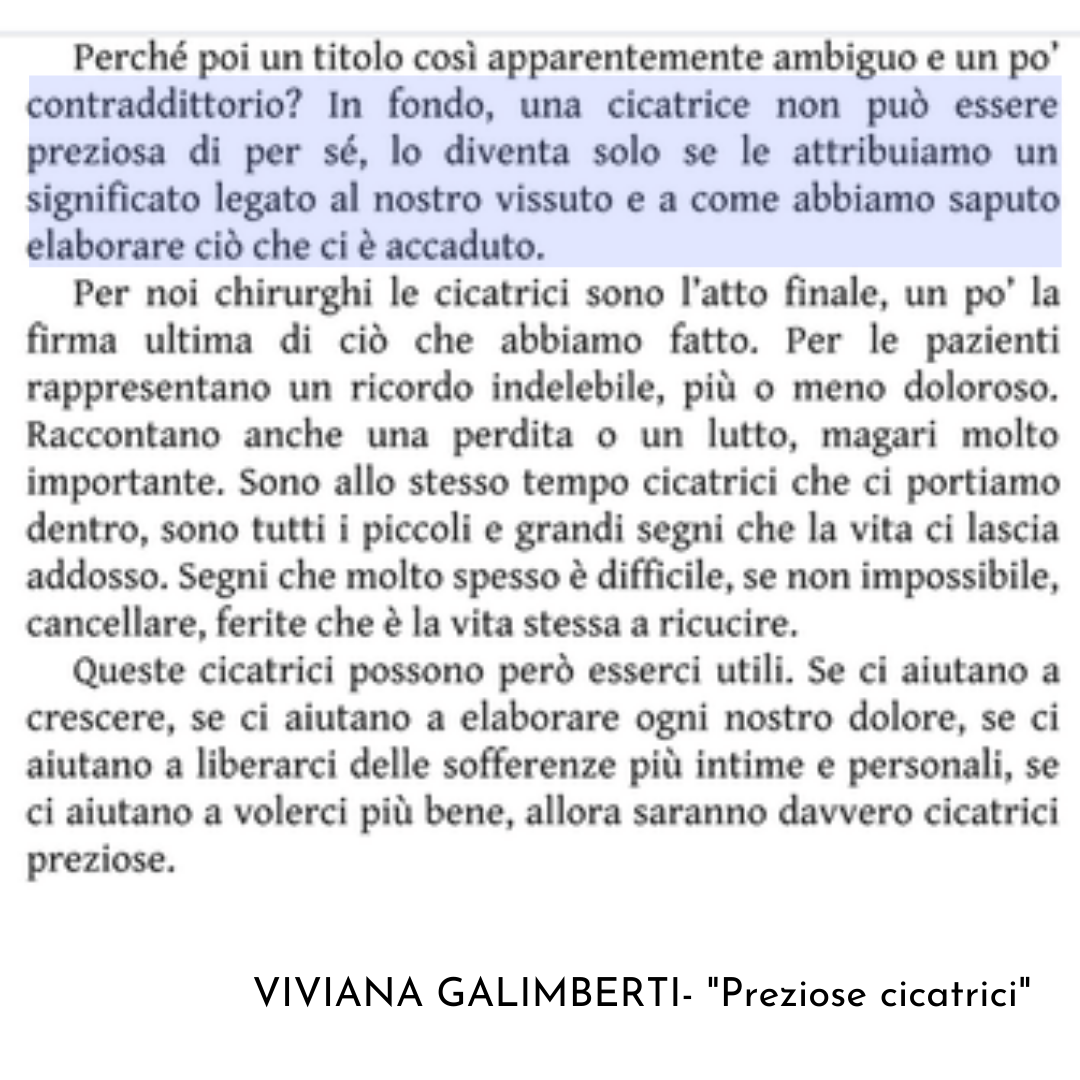


 Feed RSS
Feed RSS
